|
L’ORIGINE DEL PECCATO
Il peccato di cui si macchiarono Adamo ed Eva, quali antenati e
rappresentanti ideali dell’umanità, trae origine dalla mancanza di fede in
Dio, il loro Creatore.
A causa della primordiale disubbidienza
a Dio, l’umanità, fin dall’inizio della sua storia, si è posta sotto il
domino del peccato (il cosiddetto ‘peccato originale’)
che si trasmetterà alle generazioni future.
Però è da considerare che Adamo ed Eva, poiché non conoscevano la Legge di
Dio, che fu data in tempi successivi tramite Mosè, non avevano la conoscenza
del peccato, né potevano rendersi conto della vera natura del male e delle
tragiche conseguenze derivanti dalla disubbidienza a Dio. Possiamo affermare
che Adamo ed Eva commisero solo un peccato di “mancanza
di fede” nel loro Creatore. Gli uomini vissuti dopo Adamo fino a
Mosè, quindi, non potevano essere puniti in forza di una legge che non
conoscevano, ma per lo stesso tipo di peccato commesso da Adamo, il
capostipite dell’umanità. Per questo motivo Adamo rappresenta nella Bibbia
la figura emblematica che etichetta l’umanità “potenzialmente peccatrice”
sottomessa alla potenza del peccato per aver mancato nella fede in Dio.
E se Adamo disattese la fede nel suo Creatore, ribellandosi nel
riconoscere l’universale signoria di Dio sul creato, al contrario la Bibbia
riporta altri personaggi carismatici, vissuti prima di Mosè, che invece
hanno creduto per fede: “Abele offrì un sacrificio migliore di quello di
Caino; Noè costruì un’arca per la salvezza della sua famiglia; Abramo messo
alla prova offrì il figlio unigenito Isacco in sacrificio a Dio. Talmente
grande poi fu la fede di Abramo in Dio, che il suo ruolo nella storia della
salvezza viene riportato come il “rappresentante esemplare” di colui che, al
contrario di Adamo, ha creduto nella promessa e ottenne la giustificazione
mediante la fede in Dio.
Quattrocento anni dopo la promessa fatta ad Adamo, Dio consegnò a Mosè la “Legge”,
la quale non sostituisce né annulla la promessa precedente fatta da Dio ad
Abramo. Nelle intenzioni divine le rispettive funzioni della “promessa della
fede” e della “consegna della legge” rimangono comunque e sempre ben
distinte. |
|
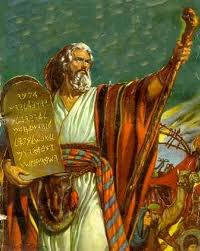 |
|
LA LEGGE DI MOSE’
La “Legge”, trasmessa da Dio tramite
Mosè, ha consentito all’umanità peccatrice, macchiata alle origini dal
peccato originale, di prendere coscienza e conoscenza della vera natura del
peccato di disubbidienza a Dio. Paolo afferma: “Tutti gli uomini,
credenti e non credenti, sono permanentemente sotto il dominio del peccato
del male. Nell’indole dell’uomo non abita il bene, ci può essere il
desiderio del bene, ma senza la Legge di Dio l’uomo, da solo, non è capace
di attuare il bene”.
La Legge costituisce una norma esteriore di condotta che sul piano divino
svolge il ruolo primario di ‘rivelare il peccato alla coscienza dell’uomo’.
Pertanto va considerata come una “legge morale” data da Dio per indicare
all’uomo la via da seguire. La Legge in sé è buona e santa, in quanto
esprime la volontà di Dio, e i suoi effetti sono l’espressione precisa del
disegno di Dio ma, poiché fu interpretata dagli uomini del tempo in senso
legalistico e punitivo, è incapace di conferire pienamente la salvezza;
rappresenta “solo” una guida di natura prettamente etica aperta al dono
della vita. Nelle intenzioni divine la Legge svolge la funzione primaria di
smascherare il peccato ma, indirettamente, potrebbe anche favorire il
peccato, perché è in grado di indurre alla trasgressione e di scatenare ogni
sorta di desideri e di passioni peccaminosi. Dio vuole liberare e unire
tutti gli uomini per mezzo della fede, ma gli effetti prodotti dalla
osservanza della legge di Mosè potrebbero produrre l’assoggettamento del
popolo di Dio ai condizionamenti umani, contrapponendo i Giudei (cioè i
credenti) ai pagani (i non credenti). Paradossalmente la Legge potrebbe
diventare motivo per l’espansione del peccato! Per essere salvati quindi non
basta solo conoscere la legge e metterla in pratica, è necessaria anche la ‘luce
della fede’, in grado di rivelare il senso della vita dell’uomo
schiavo del peccato.
Dice Paolo testualmente nella lettera ai Galati: “Nessun uomo può essere
giustificato attraverso la pratica delle opere della legge che assoggetta e
divide, ma è salvato per mezzo della fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio”.
In conclusione possiamo affermare che la legge di Mosè si può considerare
come una “tappa provvisoria” della storia della salvezza, ma la sua funzione
non è stata direttamente liberatrice. La legge che Dio ha consegnato a Mosè
è servita primariamente a rendere il peccatore più responsabile e più
cosciente di fronte al male, con l’intento di “custodire” gli uomini in
attesa della venuta di Gesù Cristo, l’unico che può rendere libero l’uomo
definitivamente dal peccato. |
|
“La Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia
e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo”
(Gv 1,17)
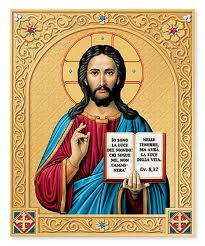
|
|
UNITI E SALVATI NELLA FEDE IN GESU’ CRISTO
Gesù Cristo non è venuto sulla terra per
proporre un codice morale diverso da quello dell’Antico Testamento. La legge
di Mosè costituisce una norma di condotta non superata perché rappresenta un
indirizzo morale di carattere universale. Gesù, in definitiva, non solo
conferma la legge ma la perfeziona, affermando che l’antica legge di Mosè
trova compimento nel precetto dell’amore alla luce della misericordia di
Dio.
L’uomo, unito nella fede in Gesù Cristo, non ha più nessuna esigenza morale
di sottomettersi o sottostare ad una legge fondata sul principio della
sentenza di condanna. La novità più importante portata da Gesù è stata il
dono dello “Spirito di Dio” che ci ha lasciato poco prima di congedarsi da
questo mondo. E’ il dono dello Spirito Santo che ha liberato l’uomo
dal legalismo della legge che nel passato aveva procurato odio e divisione.
Lo Spirito di Dio ci ha abilitato ad amare il prossimo, come ha fatto e
insegnato Gesù durante la sua vita terrena. Con Paolo possiamo affermare che
lo Spirito Santo ci ha riscattato dalla “maledizione della legge” che fino
alla venuta di Gesù non era stata in grado di salvare l’uomo dal peccato.
Unito e rinnovato dallo Spirito di Dio, il credente ora è in grado di
scoprire e capire da se stesso il senso della legge di Mosè e può aderire
alla Legge di Dio che non rappresenta più una costrizione esterna, ma la “legge
naturale” della sua nuova vita, la “legge del
cuore” basata sull’amore di Dio e del prossimo. |
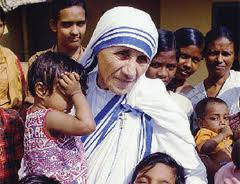
FEDE E OPERE
|
C’è comunque da considerare e da capire meglio il peso e il ruolo
effettivo svolto dalla fede nel raggiungimento della salvezza.
Fermo restando che la salvezza non si può ottenere solo tramite le opere
della legge, spesso ci poniamo queste domande: “La salvezza è raggiunta
mediante la sola fede in Gesù Cristo?” “Siamo salvati credendo semplicemente
in Gesù Cristo o è necessario anche produrre opere buone?” “Se una persona
afferma di essere credente, ma non agisce di conseguenza, perché non
annovera nella sua vita opere buone, quale valore ha la sua fede?”
Secondo Paolo: “l’uomo non è salvato per le opere della legge ma
lo è soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo” (Gal 2,16; Rom 3,28).
Nella lettera di Giacomo leggiamo anche: “l’uomo viene giustificato non
soltanto in base alla sua fede ma anche in base alle opere, la fede senza le
opere è morta” (Gia 2,24-26).
A prima vista sembrerebbero due affermazioni in disaccordo, due tesi in
aperta contraddizione, come se Giacomo prendesse posizione contro il
principio enunciato da Paolo della giustificazione mediante la sola
fede.
In realtà Paolo e Giacomo affrontano lo stesso argomento da prospettive
diverse. Paolo, parlando contro il Giudaismo che ai suoi tempi tendeva a
svalutare la fede rispetto alle opere, ha messo in rilievo il primato della
fede.
Giacomo ha sottolineato che la fede in Cristo deve necessariamente
portare a produrre opere buone.
Sembra comunque evidente che Giacomo intenda correggere una interpretazione
troppo rigida di Paolo, cercando di chiarire il concetto che la fede, per
essere autentica, deve necessariamente portare i frutti, cioè deve sfociare
nelle opere buone. Giacomo insiste su una fede che si attua nelle opere,
soprattutto nell’amore del prossimo, al di fuori quindi di condizionamenti
fondati su paure, costrizioni o punizioni. Giacomo afferma che se uno dice
di avere fede in Gesù Cristo ma poi non compie le opere buone, la sua fede
non porta frutti e quindi non ha valore. Se Paolo da una parte afferma che
la Fede è l’opera di Dio necessaria e indispensabile a indurre nell’uomo una
vita nuova, Giacomo da un’altra angolatura spiega che le opere devono
necessariamente provare l’esistenza di questa nuova vita.
In definitiva, il messaggio che entrambi ci inviano è questo: si può abusare
tanto della fede quanto delle opere, facendo della fede uno “schermo di
sicurezza” e delle opere meritevoli un “falso appoggio”. Giacomo combatte la
prima di queste tendenze, Paolo la seconda. Entrambi gli insegnamenti sono
quindi necessari per controllare e orientare la nostra vita cristiana verso
la salvezza e, lungi dal contraddirsi, le due norme si integrano
perfettamente l’una nell’altra. |
|
|
|
CONCLUSIONE |
|
Il concetto di fede
nel corso delle varie tappe della Storia della Salvezza ha subito una
radicale evoluzione: da una fede astratta (la fede di Adamo, di Abramo, di
Giacobbe) si arriva a Mosè, con il quale, al contrario, la fede acquista un
carattere pratico e pragmatico, legato alla rigida osservanza di precetti.
Con la venuta di Gesù Cristo il concetto di fede subisce un’ulteriore
evoluzione. Gesù afferma che la fede acquista compimento nella legge, e va
vissuta nell’amore di Dio e del prossimo.
La legge senza la fede, da sola, non è in grado di salvarci dal peccato. La
fede senza la legge è debole, priva di fondamenta; per il credente
significherebbe vivere e praticare una “fede astratta e dogmatica”, slegata
dal contesto di vita reale.
La fede senza le opere è vana.
Fede e legge, fede e opere, quindi, sono intimamente legate in un regime di
stretta ‘complementarietà’, unite e congiunte in una sorta di reciproca
dipendenza, perchè l’una dipende dall’altra e l’una si completa
reciprocamente nell’altra.
La “Salvezza” si acquisisce con la fede in
Gesù Cristo.
La “Fede” per essere autentica va
concretizzata nelle opere buone affinché possa raggiungere la pienezza. |
|